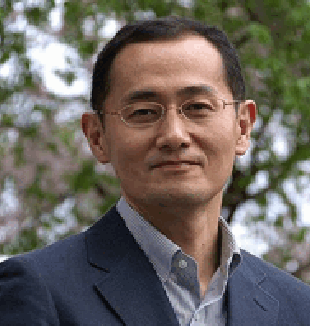
Il nobel bambino
Sabato 8 dicembre è stato consegnato il Premio Nobel per la Medicina a Shinya Yamanaka. Ma chi è lo scienziato giapponese che è riuscito a far “ringiovanire” le cellule umane? Ecco un suo ritratto dal numero di novembre di "Tracce"Era così maldestro che lo avevano soprannominato Jyamanaka. Solo una lettera in più del suo cognome: Yamanaka. Ma jyama in giapponese significa “disturbare”, “dare fastidio”. Lui, giovane chirurgo ortopedico che impiegava due ore per un’operazione di venti minuti, non si è messo a fare resistenza: se n’è reso conto, ha inchinato la testa con eleganza e ha salutato, come fa in pubblico ora che ha vinto il Premio Nobel per la Medicina.
Shinya Yamanaka è un ortopedico che ha sfatato un dogma della scienza: le cellule di un uomo, una volta adulte, non possono tornare “bambine”, cioè capaci di trasformarsi in moltissimi tipi diversi. Lui invece le ha “ringiovanite”, ha creato le staminali pluripotenti indotte (le iPS): cellule adulte che vengono riprogrammate, riportate allo stato delle embrionali. Ora i libri di medicina vanno riscritti, e non è per modo di dire.
Ma questa non è la storia del genio incompreso. È più che altro la storia di un amante della realtà, di ciò che essa stabilisce e di ciò che nasconde. La sua vicenda mostra cosa sprigiona un uomo che si abbevera dalla realtà. Nessun pensiero prima. Ci arriva davanti e la guarda bene, vede quello che è. L’apparenza la sfonda così, non perché deve o per uno sforzo, ma per il solo guardare.
È stato il padre a spronarlo a diventare medico, nonostante l’azienda di famiglia. Una piccola fabbrica di pezzi di ricambio per macchine da cucire ad Osaka, tra i grattacieli della Panasonic e gli altri giganti dell’elettronica. A dieci anni lo skyline cambia, disegnato dai templi buddhisti di Nara, sull’isola di Honshu. Oltre al padre, ci si mettono il judo e il rugby. «Sono andato in ospedale più di dieci volte per infortunio. Era naturale che mi venisse l’interesse per la chirurgia ortopedica». Naturale come accorgersi, poi, di non essere tagliato per il mestiere: «Non avevo talento. Non sarei stato utile ai pazienti così». E poi l’impotenza della chirurgia sulle malattie intrattabili lo turba. «Iniziano i dubbi sulla sua vocazione. Realizza che, per quanto salva-vita, la chirurgia non risolve i misteri persistenti della medicina», racconta Prashant Nair di Pnas, la rivista dell’Accademia Nazionale di Scienze americana. Così dopo la laurea alla Kobe University e due anni di corsia, Yamanaka lascia la clinica per il laboratorio, con un dottorato in Farmacologia all’Osaka City University. A chiarire l’interesse per la ricerca sono stati anche tre mesi, apparentemente banali, di tirocinio in Medicina legale, tra autopsie e test sull’alcolismo. «Io però mi sono sempre sentito un medico», dice oggi. Il pensiero costante è ai pazienti: «Il mio obiettivo è di portare la tecnologia delle staminali ai letti degli ospedali».
In cerca di un posto. È inciampando in un articolo sui topi knockout, “creati” in laboratorio, che resta affascinato dalla genetica. Per questo si trasferisce negli Stati Uniti, ma non ha nessun contatto: invia una trentina di lettere ad università e specialisti, prendendo i nomi dalle riviste, in cerca di un post-dottorato. Gli risponde solo il Gladstone Institute di San Francisco. È lì che si concentra sui topi transgenici: «Lo scopo era padroneggiare le tecniche con cui generarli». Ma la scoperta di uno strano enzima, il Nat1, attira all’improvviso tutta la sua attenzione. Era fondamentale nella differenziazione delle embrionali di topo, ma non si capiva il funzionamento.
È che prima di risolvere questo mistero, Yamanaka deve lasciare tutto. È il ’96. «Sarei voluto stare negli States per sempre, ma mia moglie voleva una scuola elementare giapponese per le mie figlie». È la realtà che chiama: prende e torna ad Osaka. Portando con sé qualche topo knockout. Ormai le cellule embrionali «avevano smesso di essere uno strumento delle mie ricerche per diventarne protagoniste». Vuole capire come vengono spinte ad adottare dei “destini” specifici: a diventare cellule del cuore, del fegato, del cervello. Ma la risposta del mondo accademico al suo progetto è molto tiepida. All’epoca, l’interesse per le staminali è ancora debole e in pochi possono capire la sua ricerca. Nel ’99, trova posto solo all’Istituto di Scienza e Tecnologia di Nara. Un laboratorio piccolissimo, di tre persone. E senza un ospedale universitario da cui poter prendere le cellule embrionali. Da qui, in soli sette anni centrerà l’obiettivo che ha cambiato la storia della scienza.
Yamanaka non è venuto meno al consiglio che gli diede un professore a San Francisco: «Serve visione e duro lavoro». Al lavoro non si è mai sottratto, ma per una visione più chiara gli è servita la visita casuale ad un amico, in una clinica della fertilità. Mentre parlano, gli mostra un embrione al microscopio. «Ho guardato e ho pensato che la differenza tra quelle cellule e le mie due figlie era piccolissima», dirà in una intervista al New York Times nel 2007: «Mi sono detto che se si fosse potuto far tornare le cellule ad uno stato pluripotente senza distruggere embrioni umani, sarebbe stato l’ideale. Bisognava cercare una strada alternativa». Non è lì con una preoccupazione etica, nessuna presa di posizione, pro o contro. Niente. Guardando la realtà ne vede il fondo, e vede dove “fermarsi”. Un limite, che gli allarga l’intelligenza. E in un’obbedienza ai fatti da bambino si ritroverà una capacità di leggere dentro le cose che gli altri si sognano.
«Ha fatto un lavoro massiccio, enorme. La logica che lui ha ribaltato era assodata, per questo è stato un avventuriero. Perché tutti pensavano fosse impossibile. Anch’io», dice a Tracce dall’istituto Riken di Yokohama Piero Carninci, italiano trapiantato in Giappone da 17 anni, tra i massimi esperti di genoma, a cui si deve, con la collaborazione di altri 190 scienziati, la mappatura del dna umano. «Yamanaka è un uomo energico e determinato. Non ha mai ascoltato i gufi, e questo insegna qualcosa a tutti noi. Non si può vivere accettando qualcosa solo perché è sempre stata detta. Il suo lavoro ha smentito tutti gli studi precedenti perché ha avuto un’intuizione e le ha dato credito. Ora dirlo è facile, ma è un’esperienza molto dura. Perché bisogna passare, continuamente, dal confronto, sfidare gli altri sul fatto che c’è un’altra realtà da quella che vedono».
Un avventuriero. Questo cinquantenne che non dimostra la sua età, ama lo sport e si veste casual, «molto timido e schivo, parla piano, lo sguardo basso», come raccontano dalla Fondazione Premio Balzan, i primi a “scoprirlo” in Italia. Non va ospite in tv, non parla di altro se non del suo lavoro, se si divaga riporta l’argomento lì: sa di essere ormai un “ambasciatore” del suo Paese nel mondo, per questo il Governo ne protegge ricerche ed immagine, con un protocollo complicatissimo quando si muove all’estero. Lui non manca mai di ringraziare la sua Nazione anche per il forte sostegno finanziario. E quando gli sfugge qualche battuta, insolita nel mondo accademico orientale, tradisce una certa nostalgia per l’America, mai negata: «Là nessuno s’interessava del mio passato, di quello che avevo fatto o non fatto. Celebri scienziati mi parlavano senza problemi».
«Sono stato fortunato». I primi risultati delle sue ricerche stupiscono il mondo scientifico in un congresso a Toronto, nel 2006: dimostrano che anche le cellule adulte mantengono, in forma latente, il potenziale illimitato che avevano allo stato embrionale. La sua impresa è stata trovare la formula genetica che risveglia quel potenziale. È con la pubblicazione degli studi su Cell, nello stesso anno, che iniziano a circolare le voci del Nobel. Eppure lui si è sorpreso quando una domenica mattina, il 7 ottobre scorso, il telefono è squillato mentre faceva i lavori domestici. Il Paese era pronto: nel giro di pochissimo sono andati in onda programmi e servizi. Le immagini sempre uguali: lui in camice tra i vetrini. Un «maniaco del lavoro», per sua stessa ammissione, Yamanaka sta in laboratorio dalle 12 alle 16 ore al giorno, è noto nel campus per pranzare da solo e in fretta, per poi cenare con il suo team, ma di notte, in laboratorio. Quando gli chiedono il segreto del suo successo dice di avere soltanto «una grande propensione al rischio». Ma aggiunge che gli è anche andata bene: «Conosco scienziati che lavorano più duramente e che sono più intelligenti di noi. Siamo stati estremamente fortunati». Parla di sé e dei suoi collaboratori, circa venticinque e tutti giovani, appena laureati o post-doc.
Ci sono voluti cinque anni solo per selezionare i geni che potevano indurre la pluripotenza: con centinaia di candidati, il numero di combinazioni possibili era quasi infinito. Alla fine ne hanno scelti 24, i più promettenti. «È stato quasi come prendere un biglietto alla lotteria», dice: «Ho avuto la fortuna di comprare quello giusto». Solo quattro di questi hanno dimostrato un’abilità quasi magica di resettare l’orologio di sviluppo nelle cellule dei topi. Poi la sfida è stata adottare la riprogrammazione sulle cellule umane. Ha fallito per mesi. È andato per tentativi, cambiamenti piccolissimi, come usare o no il gel per la coltura, ma che hanno operato piano piano, fino ad assistere alla trasformazione. Da lì, nuovi passi da fare, come eliminare il gene Myc, capace di causare tumori. E tuttora, rimane tanto da scoprire. Uno dei primi commenti all’annuncio del Nobel è stato: «Il mio lavoro non è finito».
La soluzione di Yamanaka è anche fatta di passi non suoi, che lo hanno preceduto. Fin dal 1962: mentre lui nasceva, John Gurdon, l’altro vincitore del Nobel, ha creato delle rane in laboratorio usando il trapianto nucleare. Da allora ad oggi, è una storia di approssimazioni, in cui i ricercatori hanno a lungo sospettato l’esistenza di un fattore misterioso, capace di riprogrammare il nucleo di una cellula. Ma è sempre sfuggito. Fino a lui.
Mentre in Giappone vanno in stampa i calendari con la data storica del Nobel, «lui ha conquistato l’opinione pubblica e ha cambiato il flusso d’attenzione sulla ricerca di base, sempre subordinata a quella applicata», conclude Carninci. Nell’attesa delle applicazioni terapeutiche, che presentano ancora molti problemi tecnici ma sono potenzialmente straordinarie - come il ricambio dei tessuti malati -, si è aperta «sulla scia del lavoro di un uomo una nuova era scientifica», come ha detto il biologo Angelo Vescovi.
Yamanaka passa alla storia per una visione della natura. L’ispirazione fissando quell’embrione al microscopio non è stata una mossa etica. Semmai è l’etica che nasce dalla realtà guardata. È stato un semplice dato, accolto, e diventato ipotesi potentissima. In un’omelia del 2008, il cardinale americano Justin Francis Rigali citò Yamanaka: «Se Dio può utilizzare un embrione indifeso per cambiare la vita di un uomo, può certamente usare di noi, con tutti i nostri limiti e le nostre debolezze».