
Gioventù Studentesca. I libri per l'estate
Sono il Miguel Mañara di Oscar V. Milosz ed È mezzanotte dottor Schweitzer di Gilbert Cesbron. Due uomini, due storie. Per tornare a guardare la posta in gioco nella vitaMiguel Mañara
Immagino i miei studenti che, già scettici sugli scrittori italiani, si vedano proporre un drammaturgo lituano. Qualcuno dei più diligenti andrebbe a cercare dove si trova la Lituania, terra di foreste e di laghi. A dodici anni Oscar Vladislas Milosz andò in Francia, dove il padre si trasferì in occasione di quella Esposizione Universale (Expo 2015 per intenderci) del 1889 che ha regalato al mondo la Tour Eiffel. Qui, dice, fu educato secondo «i principi del più ingenuo e brutale libero pensiero». Chissà cosa inseguiva il padre di Vladislav nel viaggio da Czereia a Parigi, e chissà cosa avrà pensato leggendo nel primo atto del Miguel Mañara, il protagonista, lamentare: «Com’è breve questa vita per la scienza!». Potremmo declinare così la sua denuncia: la scienza - ma per non prendersela troppo con la scienza potremmo pensare a quell’educazione ingenua e brutale del libero pensiero sopracitata - può dirmi al massimo che la mia vita, sulla scala della Storia universale, è un piccolo, minuscolo frammento. Questo però, non appaga né “spegne” il protagonista della sua opera più famosa, che proviamo a conoscere in queste righe.
Nel primo quadro Miguel Mañara – uomo realmente esistito nella Siviglia del 1600 – sta festeggiando i suoi trent’anni in compagnia di alcuni commensali. Anche loro, come lui, vivono nel segno del vizio, ma nessuno lo eguaglia. Sulla sua coscienza pende un numero puntigliosamente elencato di donne: duchesse, marchese, nobildonne, borghesi, sgualdrine, perché questo è ciò che più definisce il personaggio, rampollo della nobiltà del siglo de oro che trascina l’amore «nel piacere, nel fango e nella morte». Attenzione però: la sua non è una semplice ribellione; smaschera anzi l’ipocrisia di chi è lì a suo fianco, ma si tirerebbe indietro di fronte a qualche giudizio morale; egli non ha il problema di essere ubbidiente a leggi scritte o non scritte, ma avverte di non essersi avvicinato neanche minimamente all’essere sazio. «Ho perduto Satana» dice il protagonista, privato cioè del gusto stesso del male, «mangio l’erba amara dello scoglio della noia». La noia di Miguel non è solo un pensiero astratto, una percezione d’intelletto, ma è una concretissima “erba amara”, come fosse lì sulla tavola su cui Miguel sta mangiando. Ogni “pasto” è diventato simile, in consistenza e gusto, a una di quelle foglie d’insalata tenute per troppo tempo aperte nel frigo, avete presente? Miguel insegue ovunque una «bellezza nuova, un nuovo bene di cui presto ci si sazi»; valuta persino «un nuovo dolore», ma nemmeno questo lo placa. «Come colmarlo quest’abisso della vita? Che fare? Perché il desiderio è sempre lì, più forte, più folle che mai». I suoi trent’anni sono riassunti qui: nella ricerca insaziabile di qualcosa che soddisfi, nell’«infinito di vite nuove» purché ce ne sia una, almeno una, che colmi quell’abisso.
Dal fosco scenario in cui si collocano le parole di Miguel nel primo atto, capiterà di «risvegliarsi di soprassalto in una bella camera in cui ogni cosa è immersa nella musica discreta della luce». È un po’ strano pensare che una nuova fase della vita sia paragonabile a una stanza, ma facciamo questo sforzo per seguire il personaggio: immaginiamoci la camera. Una luce, tanta luce, tanta da dominare ogni angolo, come se fosse musica. Poi magari dei fiori, alla finestra. No! I fiori no! Sono bellissimi i fiori, ma proprio per questo bisogna «lasciarli vivere e respirare l’aria del sole e della luna. Si può benissimo amare senza aver subito voglia di uccidere il proprio caro amore, o di imprigionarlo tra i vetri». Niente fiori, direbbe Girolama, la giovane ragazza che posta di fronte a Miguel non ha paura anzi, dice, «non vedo cosa ci sia di così terribile» nella vita di lui: lì, di fronte a lei, la sua esistenza non sembra più tanto tremenda. Miguel, il grande amatore, conosce chi saprà accendere «una lampada nel suo cuore».
Mattia Gennari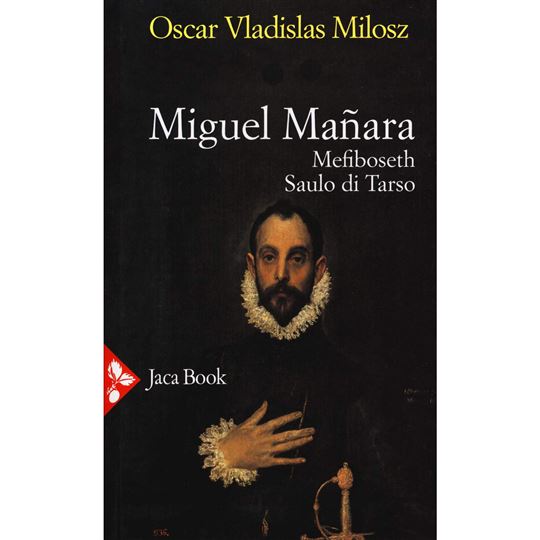
È mezzanotte dottor Schweitzer
Mollare tutto e andare. Non per un capriccio, ma per rispondere alla vita che chiama: «La responsabilità di ognuno di noi, di fronte a tutto ciò che vive, è totale». Nel dramma teatrale È mezzanotte dottor Schweitzer (1954) Gilbert Cesbron ci mostra la giornata di un uomo – Albert Schweitzer – che agli inizi del Novecento lascia in Europa famiglia, cattedra universitaria e carriera da pianista per «assumere una parte del fardello del dolore umano», andando a fare il medico in Congo e mettendo insieme «trenta baracche, trecento letti» dove «prima non c’era nulla»: «Che Iddio esista o no, il viso di un uomo che soffre è lo stesso e a vederlo il mio cuore si stringe».
Al cospetto di eroi simili ci si sente minuscoli. Si capisce che la vita va spesa. I piccoli calcoli per sistemarsi borghesemente appaiono ripugnanti: la pagella è a posto, l’estate anche, per il futuro proveremo qualche test... e invece: io cosa posso dare a questo mondo? Ti alzi dalla sedia e vai a trovare i tuoi alunni sotto casa, provi a consumarti per loro, te ne inventi mille ogni mattina.
C’è un solo problema: alla fine, comunque vada, perdi. È come spostare un macigno solo di un millimetro. Ecco perché quasi tutti ci rinunciano in partenza. E per giunta si atteggiano a saggi: «Poiché non amano nessuno, credono di amare Dio», sentenziava Péguy. Chi rischia, al contrario, si brucia. «Ho rinunciato alla musica, all’insegnamento, a tutto quello che amavo; ho voltato faccia alla vita per arrivare qui e loro rubano le provviste dell’ospedale», dice Schweitzer
Io mi sveno, e loro se ne infischiano. Ne vale la pena? Di tutte le parole, gli entusiasmi, le pene di un anno scolastico, cosa resta? di quello che proviamo a costruire per i nostri amici? «Solo il cimitero rimarrà riconoscibile quando le termiti avranno divorato il mio ospedale, quando la foresta avrà cancellato tutto». Bisognerebbe affidare i nostri tentativi nelle mani di Dio. Sì, ma basta? A mezzanotte di un giorno del 1914 comincia la guerra, e Schweitzer è costretto a farsi da parte: addio dedizione, addio ospedale. «Dovrei accettare questo destino e rimettermi a Te in completa fiducia; mentre soffoco di amarezza e di angoscia».
Ci si può sacrificare per gli altri e morire di angoscia. Quando arriva mezzanotte anche nell’anima, ci si sente «impotenti e desolati»: l’ingiustizia non la smuovi, e tutti i conti si rivelano indubbiamente negativi. Ma un conto non torna. C’è qualcuno – anche lui in prima linea nel cuore dell’Africa – che ogni volta perde e ogni volta ricomincia: «Padre, lei sorride sempre, perché?».
Eppure padre Carlo è inconcludente («fra tutti i missionari tu sei quello che conta meno conversioni al suo attivo»), né si consola con ingenue storielle a lieto fine: le favole «finiscono sempre alla soglia della felicità». Come dare torto al dottor Schweitzer? «Che sconfitta padre Carlo! Da due anni siamo installati qui, lei e io, e si sacrificano ancora dei bimbi malati... Che sconfitta!».
Sconfitti, certo, ma non l’abbiamo sempre saputo che ad amare non si vince nessun premio? che il nostro compito è «avviare processi» (che altri puntualmente distruggono)? che «per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te?». Cos’è cambiato, allora, se l’ingratitudine ci rode lo stomaco? Ci siamo messi a fare bilanci. E una volta appassite le rose che nascondevano la voragine, veniamo risucchiati dal vuoto che generosamente riempivamo.
Quel prete fallito e sorridente ci inchioda però a una controdomanda: «Posso domandarle, io, perché lei non sorride più?». Amiamo la nostra immagine eroica da insegnanti attorniati da alunni entusiasti anziché questi «esseri miserabili» che non sanno cosa farsene delle nostre belle lezioni, ecco tutto. Perché mai gli altri non si accorgono di noi e dei nostri ideali? Sarebbe inevitabile diventare cinici come tutti, se non fosse che esistono delle eccezioni, in cui nessuna delusione scalfisce la pienezza. «Anche perché – scriveva Pavese – sono tutti capaci a innamorarsi di un lavoro che si sa quanto renda; difficile è innamorarsi gratuitamente».
Valerio Capasa